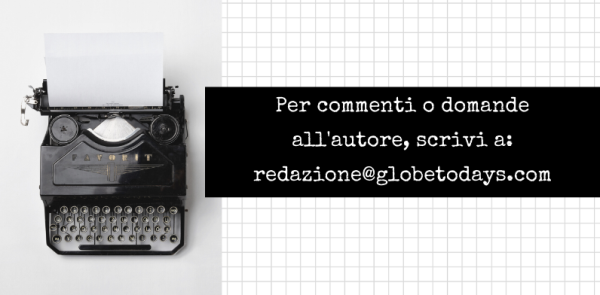“Dante Alighieri: Viaggio Straordinario nella Commedia”
Quanto sappiamo davvero di Dante e della sua Commedia? Quanti di noi che hanno fatto il liceo sono rimasti convinti delle interpretazioni dei nostri insegnanti? Ve lo chiedo perché in questi ultimi anni Giuliano Di Benedetti, un architetto ricercatore di Genzano, cittadina laziale ai confini della selva nemorense, citata nelle memorie di Augusto e da Virgilio, dà un’interpretazione diversa della Via di Dante. Se avete un minimo di curiosità, percorriamola insieme.

Un mistero: Dante e la sua Commedia
“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la dritta via era smarrita”.
Chi non conosce questi versi immortali di Dante che sono l’incipit della Commedia, divenuta “divina” grazie al Boccaccio? Un po’ più complicato è darne la corretta interpretazione, benché come ex studente del liceo, molto ex per la verità, sia sempre stato concorde con il mio professore dell’epoca che considerava quei versi come l’ammissione di Dante di trovarsi in un certo momento della sua vita in crisi, sia morale sia spirituale. Ma siamo sicuri che ci sia soltanto questa interpretazione? E se ce ne fosse anche un’altra, come ipotizzava Giuliano Di Benedetti prima di lasciare il suo corpo un paio di anni fa, nel suo straordinario saggio “La via di Dante”?

Se non fosse solo Dante a smarrirsi, ma anche la via, che da dritta e lineare, a un certo punto del suo itinerario, si confonde con la selva oscura? L’unica via che conosciamo e conoscevano anche gli antichi e che è dritta per antonomasia, era ed è l’Appia antica. Da Roma a Terracina è un rettifilo lungo 90 km, poi, improvvisamente, diventa sinuosa da Albano Laziale fino a Genzano. Per superare il dislivello della vallata di Ariccia, la strada diventa impervia, in un saliscendi continuo per adeguarsi alle pieghe del terreno ed è proprio lì che il Poeta finisce con il ritrovarsi in una selva oscura,
“Ahi, quanto a dir qual era è cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura”.Dov’è la Selva?
A questo punto ci si presenta un altro quesito: dov’è questa selva cantata da Dante e che solo al ricordo lo fa fremere di paura? Se davvero stava percorrendo la via Appia e finisce per perdersi in una selva, essa non può essere che la selva opaca cantata da Ovidio, il nemus, l’intricato bosco nemorense che circonda il lago di Nemi, la selva di Diana, la dea protettrice degli animali selvatici, custode delle fonti e delle correnti.
"Ma poi ch'io fui al piè di un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto, e vidi le sue spalle vestite già de' raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogne calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte ch'io passai con tanta pieta".L’ingresso al mondo dei morti
È chiaro in ogni caso il riferimento del Poeta a una valle ai piedi di un colle, le cui spalle sono illuminate dai raggi del sole che sorge. È precisamente il panorama che si può ammirare dal bordo del cratere nemorense, nelle vicinanze del luogo che Virgilio e Augusto, che era passato per quei luoghi prima di Dante, consideravano come l’ingresso del mondo dei morti. Dal fondo del cratere il Poeta prende a salire lungo l’erta:
“Poi ch’ei posato un poco il corpo lasso
ripresi via per la piaggia diserta,
sì che ‘l piè fermo sempre era ‘l più basso”.
Ed ecco che incontra tre belve. Prima una lonza o meglio un leopardo o una pantera:
"Ed ecco, quasi al cominciar de l'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel maculato era coverta".

Subito dopo un leone:
"Questi parea che contra me venisse con la test'alta e con rabbiosa fame sì che parea che l'aere ne tremesse".

Infine, una famelica lupa:
"che di tutte brame sembiava carca ne la sua magrezza e molte genti fé già viver grame...".

L’enigma delle tre belve
Le tre belve sono un altro degli enigmi praticamente irrisolti della Divina Commedia. Tra l’altro, data la grandezza del Poeta, sembra davvero misera l’interpretazione che si dà delle tre fiere come simboli rispettivamente della lussuria, della superbia, dell’avarizia, i vizi capitali che corrodevano come un cancro ogni potere politico. Ci doveva essere qualcosa di più. Lonza, leone, lupo, suggerisce Giuliano Di Benedetti, sono le tre belve, a detta del profeta Isaia, che convivevano pacificamente con l’agnello, il capretto e il vitello, nel paradiso terrestre. I tempi sono cambiati e le tre belve tornano a fare paura ai viandanti per tenerli lontani da qualcosa.
Che cosa rappresentano davvero? Quale rapporto può esserci tra ciò che descrive Dante e l’enigmatico ritrovamento del 1895 nel lago di Nemi delle tre teste bronzee di questi animali? L’imperatore Caligola aveva utilizzato quelle stesse tre belve come simboli esoterici e in funzione apotropaica per tener lontano il male, a difesa del suo tempio galleggiante, dedicato alla dea Iside, sposa di Osiride, divinità degli Inferi. Tuttavia, le navi che ospitavano i bronzi erano affondate nelle acque del lago da più di mille anni, come faceva Dante a sapere cosa ci fosse a bordo? E ancora, qual era il collegamento tra le tre fiere e un altro enigma ancora più persistente, quello del veltro? Ma andiamo per ordine.
Dante incontra Virgilio
A questo punto Dante incontra Virgilio, che diventerà la sua guida. Perché proprio Virgilio? Virgilio era un profondo conoscitore del nemus che aveva descritto nell’Eneide e sia lui che Augusto conoscevano la storia del ramo d’oro, il lasciapassare richiesto da Proserpina per consentire ad Enea di entrare nel regno dei morti. Proserpina è l’accezione infera della dea Diana, alla quale era consacrata la selva nemorense con al centro l’albero sacro con il ramo d’oro. Ma torniamo alla famelica lupa contro la quale Virgilio profetizza:
"A te convien tenere altro viaggio, se vuo' campar d'esto loco selvaggio: ché questa bestia, per la qual tu gride, non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo 'mpedisce che l'uccide; e ha natura sì malvagia e ria, che mai non empie la bramosa voglia, e dopo 'l pasto ha più fame che pria. Molti sono li animali a cui s'ammoglia, e più saranno ancora, infin che 'l veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazion sarà tra feltro e feltro".
Ma chi ucciderà la lupa?
Chi è questo misterioso veltro che farà piazza pulita di tutte le ingiustizie? Chi ucciderà la lupa? Dante è uomo del Trecento, ma sa più cose di quante ne può sapere oggi un uomo comune del ventunesimo secolo. E lo dimostrerà nel corso della Commedia. È al corrente dei segreti esoterici dei Fedeli d’amore, dei Rosacroce, dei Templari, dei Catari ed è nemico giurato della Chiesa che agisce con l’arroganza dei poteri forti per mettere sotto controllo le coscienze tramite l’ignoranza della verità. Come si può pensare allora che la lupa simboleggi soltanto l’avarizia e la cupidigia degli uomini? E soprattutto perché spaventa così tanto Virgilio al punto da suggerire a Dante un percorso alternativo addirittura nell’Aldilà per evitare di cadere nelle grinfie della belva? Dante è sicuro della sua profezia, sa qualcosa di tanto potente, di un veltro che azzannerà la lupa e la farà morir con doglie.
Il punto è: come fa a saperlo? Sa che il veltro non è una persona, un principe che armi alla mano abbatterà il potere, ma una macchina che i Catari conoscono ma in Occidente non è stata ancora costruita. Dante la conosce o meglio ne conosce i principi ispiratori, ma non ne può parlare in termini chiari per non correre il rischio di finire sul rogo inutilmente. Il veltro, nella sua accezione, è un cane da caccia che azzanna la preda e non la molla finché non muore. Il veltro, i cui disegni provengono dall’Oriente, scrive nel suo libro Giuliano Di Benedetti, è la formidabile ma ancora sconosciuta ai più, ma non certo agli iniziati, macchina da stampa a caratteri mobili, veloce come un veltro, mentre la carta è il feltro su cui potrà rimanere impresso – meccanicamente e innumerevoli volte – il contenuto di un libro, la conoscenza.
Lo scopo della grande Opera di Dante
Ecco lo scopo della grande Opera di Dante: abbattere il potere di controllo della Chiesa attraverso la larga diffusione della conoscenza, della cultura, l’unico modo per liberare le menti rese schiave dall’ignoranza della verità.
Nel 1300, anno del Giubileo, Dante è a Roma e, probabilmente ispirato dalla lettura dell’autobiografia di Augusto, che aveva computo lo stesso tragitto, ripercorre l’Appia che da diritta via per antonomasia si smarrisce nell’intrico della selva che circonda il lago di Nemi, epicentro del bosco sacro della dea Diana. È qui che le antiche tradizioni pongono l’antro a guardia del quale era il rex nemorensis, il custode dell’ingresso dell’Averno, il mondo dei morti, il regno di Proserpina-Diana.
Davanti al panorama del lago di Nemi con il Monte Cavo sullo sfondo, immaginando di entrare nell’antro ritenuto da Augusto e da Virgilio l’ingresso del regno dei morti e di proseguire nella direzione di Monte Cavo, il Poeta può aver concepito l’idea dell’inferno posto sotto Monte Cavo. Non gli sarebbe stato poi difficile immaginare lo stesso monte come quello del Purgatorio e di poterlo raggiungere attraverso un condotto verticale. Il panorama era perfetto per il suo viaggio immaginario.
Visitando la vallata del lago di Nemi, Dante non può non aver avuto il desiderio di visitare un’opera che aveva avuto grande fama nell’antichità: proprio l’emissario del lago, opera di alto valore d’ingegneria idraulica degli Etruschi. Nelle viscere della montagna, Dante aveva potuto vedere non solo la forma del cunicolo dell’emissario, ma anche quella dei pozzi di ventilazione del cunicolo stesso.
Nelle viscere della terra
Esplorare le viscere della terra percorrendo antichi budelli sotterranei è un’avventura emozionante. Là sotto, ci ha detto Giuliano Di Benedetti il giorno che siamo andati a trovarlo, si ha davvero la sensazione di vivere in un altro mondo e chi è dotato di fervida fantasia può immaginare quello che vuole, anche di vedere il regno dell’oltretomba. Non solo l’Appia antica, dunque, poteva essere stata l’ispiratrice della dantesca dritta via e il bosco sacro a Diana essere stato facilmente trasformato nella selva oscura dove il Vate si smarrisce, ma anche la conformazione della valle del lago di Nemi con il bosco e il vallone cosiddetto di Tempesta possono aver suggerito l’idea dell’ingresso al mondo dei morti e la successiva risalita alla base del monte del Purgatorio.
L’emissario del lago di Nemi può – credibilmente ora – essere servito da modello per la descrizione dell’ambiente sotterraneo dov’è l’oltretomba e dove Dante immagina l’inferno e dal quale può risalire arrampicandosi faticosamente per uno dei pozzi di ventilazione che può vedere nell’emissario e trovarsi ai piedi del monte del Purgatorio.
"Luogo è là giù da Belzebù remoto tanto quanto la tomba si distende, che non per vista, ma per suono è noto d'un ruscelletto che quivi discende per la buca d'un sasso, ch'elli ha roso, col corso ch'elli avvolge, e poco pende. Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo; e sanza cura aver d'alcun riposo, salimmo sù, el primo e io secondo, tanto ch'i' vidi de le cose belle che porta 'l ciel, per un pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle".
Un percorso tanto buio che solo l’orecchio…


Come si vede, ha continuato Giuliano Di Benedetti, i versi si riferiscono proprio a un percorso sotterraneo scavato nella roccia, tanto buio che il ruscelletto viene individuato solo con l’aiuto dell’orecchio che percepisce il lento scorrere dell’acqua, un percorso che somiglia in modo straordinario all’emissario del lago di Nemi. Partendo poi da questa angusta galleria, i due poeti, per tornare a vedere la luce, si accingono a seguire un faticoso percorso.
Se si osserva bene il pozzo di ventilazione si vedranno dei buchi sfalsati nella pietra, buchi che avevano permesso a chi aveva scavato il cunicolo di sorreggersi sulla punta dei piedi e di farsi strada nella roccia fino a raggiungere la superficie. L’operaio che aveva fatto il lavoro di scavo si serviva di questa scala scavata nella roccia per salire e scendere. In questi pozzi di soli 50/60 cm di diametro poteva passare un solo uomo per volta e la salita era senz’altro faticosa perché era necessario procedere in verticale e l’appoggio del piede era limitato. Infatti:
"Lo duca e io per quel cammino ascoso intrammo a ritornar nel chiaro mondo e sanza cura aver d'alcun riposo, salimmo sù, el primo e io secondo".
A riveder le stelle!

Uscito a riveder le stelle, Dante si volge intorno a guardare il luogo dove è approdato. È un’isola sulla quale si eleva un monte a forma di tronco di cono. Osservando il cielo stellato – l’alba è vicina – Dante si meraviglia di vedere un gruppo di 4 stelle, la Croce del sud, che può essere visibile soltanto dall’altro versante del pianeta. Anche stavolta Dante ci fa capere che conosce cose che gli uomini del suo tempo non potevano sapere: che c’erano altri continenti oltre le colonne d’Ercole, ma soprattutto che la Terra è sferica. Tornando a volgere gli occhi a terra, Dante si accorge che lui e Virgilio non sono più soli, c’è una terza figura umana accanto a loro: un vecchio canuto, ieratico, con una gran barba bianca.
Dante non lo cita per nome, ma non è difficile identificarlo. È Marco Porcio Catone l’Uticense. Non è per le sue doti di grande romano che Dante lo promuove come custode del Purgatorio, ma per motivazioni che finiscono per dare ragione a Giuliano Di Benedetti. Catone aveva la sua residenza proprio sui colli albani che da lui prende il nome: Monte Porzio Catone. Virgilio ottiene da lui il permesso per Dante di passare oltre, da persona viva e per un motivo che proprio a Catone non dovrebbe dispiacergli dato che per esso si è tolto la vita. Infatti, anche Dante:
"libertà va cercando, ch'è sì cara come sa che per lei vita rifiuta"
È lì per percorrere la sua via di libertà.

Giornalista – Direttore Responsabile Globe Today’s